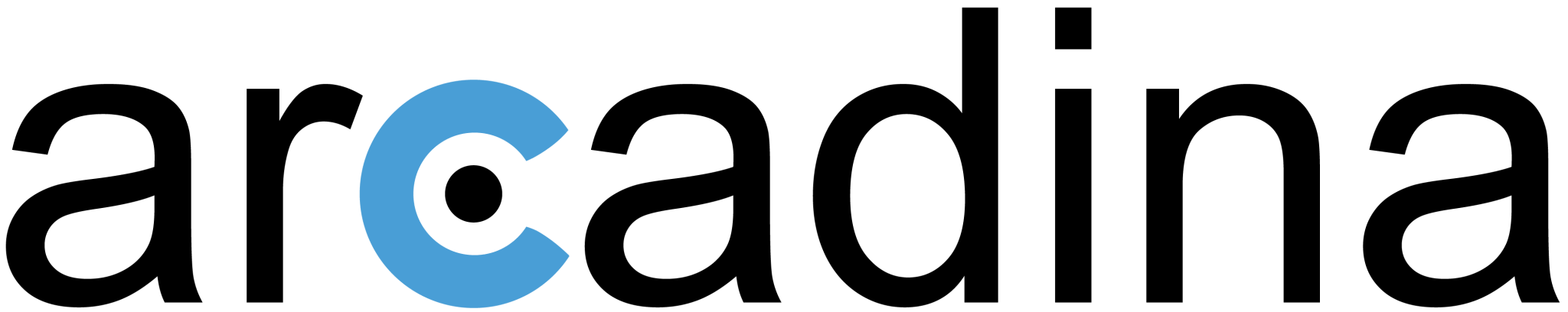La fotografia ai tempi dei #fotografi@ (seconda parte)
Blade Runner (Ridley Scott, 1982) ci ha mostrato un futuro che, a novembre 2019, è diventato distopico sotto molti aspetti. Sebbene molte delle città di oggi assomiglino a quella Los Angeles futuristica, tetra, squallida e satura di luci al neon (ora a LED), la verità è che la robotica, l’intelligenza artificiale e l’ingegneria genetica sono ancora agli albori. L’umanità non ha colonizzato lo spazio e la cosa più simile a un’auto volante che abbia mai visto è la Ford Thunderbird di Thelma e Louise.
Ma Blade Runner, capolavoro indiscusso del cinema, e non solo della fantascienza, dovrebbe essere una visione obbligatoria per ogni amante della fotografia cinematografica, o della fotografia in generale. Ci ha regalato alcuni dei manufatti più iconici della storia del cinema, come gli spinner, il blaster con cui Rick Deckard eliminava i replicanti con un colpo netto, o il famoso test case Voight-Kampff. Ma senza dubbio il gadget che sicuramente ha fatto la gioia di ogni fotografo prima dell’era digitale è stata la macchina per l’analisi fotografica Esper.

Contenido
Blade Runner
Per coloro che non hanno visto Blade Runner (e questo è sufficiente!), vi dirò di cosa si tratta. Rick Deckard (Harrison Ford) è un poliziotto di Los Angeles incaricato di eliminare 4 “skinjob”, che è il soprannome dispregiativo dato ai replicanti, androidi creati dalla Tyrell Corporation, a immagine e somiglianza degli esseri umani, attraverso l’ingegneria genetica del tipo buono, e non quella della pecora Dolly. Questi replicanti finiscono per essere così perfetti che potrebbero persino superare in intelligenza i loro stessi creatori umani, cosa che, visto come sono messe le teste al giorno d’oggi, potrebbe non essere così difficile.
Ma il fatto è che col tempo questi umanoidi iniziano a sviluppare capacità emotive non lontane da quelle di qualsiasi mortale, ponendosi le stesse domande vitali che senza dubbio ci hanno fatto perdere il sonno più di una volta… Chi siamo? Da dove vengo? Quanto vivrò? Questo porta a una ribellione dei replicanti Nexus-6, i più avanzati tecnologicamente, che fuggono da una colonia esterna per andare sulla Terra alla ricerca dei loro creatori, dove l’Unità Blade Runner a cui appartiene Deckard ha il compito di dar loro la caccia ed eliminarli.
La macchina Esper
Nella famosa scena dell’analisi fotografica vediamo Deckard introdurre una fotografia nella macchina Esper, che è in grado di ingrandire un’immagine stampata (presumibilmente su carta fotografica) a un livello di definizione tale che, beh, accettiamo il polpo come animale da compagnia perché si tratta di un film di fantascienza. Ma c’è di più: non solo ingrandisce, ma grazie a un sistema di coordinate in stile Affondamento della flotta, può variare l’angolazione da cui è stata scattata la foto, rivelando parti nascoste della stanza fotografata che apparentemente non sono visibili nell’immagine.
Si è speculato molto sul funzionamento della macchina Esper, con teorie molto interessanti per qualsiasi appassionato di fotografia, ma non è la parte tecnologica a motivare questo post, bensì quella, per così dire, antropologica… Quella che fa sì che l’immaginario di un film di fantascienza abbia così tanti legami con il nostro comportamento umano nel mondo reale.
La fotografia in Blade Runner
Perché la fotografia è così importante in Blade Runner? Perché si scopre che a questi replicanti, con l’intenzione di renderli “più umani degli umani”, è stata impiantata una sorta di memoria artificiale sotto forma di ricordi, che dà loro lo status di sapere di essere vivi. Perché ricordare è la prova che hanno avuto una vita, un argomento fondamentale per comprendere buona parte del film e che nel nuovo (e anch’esso fantastico) adattamento dell’universo di Blade Runner recentemente realizzato da Denis Villeuneve, Blade Runner 2049, acquista un livello superiore con l’incorporazione di una tecnica che, al giorno d’oggi, ci è totalmente riconoscibile: la realtà virtuale.
Infatti, le fotografie che appaiono nel primo Blade Runner, presumibilmente scattate dai replicanti stessi o forse create dagli ingegneri della Tyrell Corporation, sono un’ossessione per uno degli androidi, Leon Kowalski (Brion James). Al punto da mettere in pericolo la sua breve vita artificiale (4 anni secondo la trama) per cercare di recuperarli. Sono la prova inconfutabile della loro esistenza, alla quale si aggrappano, rifiutando di accettare la loro condizione non umana, un prodotto fabbricato per essere schiavo di chi li ha creati. La fotografia come prova della vita, per le sue proprietà “indiscutibili” di realismo. Penso, quindi sono… No. Esisto perché ricordo…
Associazione tra memoria e fotografia
L’amalgama tra memoria e fotografia non è, ovviamente, qualcosa di inventato da Blade Runner. La capacità evocativa della fotografia di farci ricordare è qualcosa di intrinseco alla sua esistenza fin dalle origini.
Frammenti di realtà intrappolati in un formato limitato la cui efficacia nel trasportarci nel momento vissuto è ancora travolgente, ancor più di un home video, che in teoria dovrebbe essere una scorciatoia più efficace per la nostra memoria grazie alla sua condizione di continuità e movimento. Ma la capacità che una singola fotografia ha di trasmettere informazioni al nostro cervello e di risvegliare in noi emozioni è ancora imbattibile. In un video si vede l’azione e la nostra mente si concentra su di essa, ma con una foto il ricordo viene proiettato nel nostro cervello e può essere rivissuto con tutti i cinque sensi, e persino ingrandito, cosa che finisce per accadere con il passare del tempo…
Perdere un account Instagram è come perdere la prova della nostra esistenza, anche se è stata costruita artificialmente come la memoria dei replicanti…
L’evidenza che la fotografia, oggi, continua ad avere un’importanza vitale nella nostra vita è innegabile. Uno dei social network fondamentali per gli aspiranti influencer e per guadagnare status sociale in quella sorta di vita parallela che conduciamo su Internet, è stato concepito quasi esclusivamente per la pubblicazione di fotografie, mantenendo una certa austerità in termini di funzionalità per il semplice motivo che non ha bisogno di aggiungere altro alla formula.
Ma Instagram è diventato una collezione travolgente di momenti fotografati così preziosi che perdere un account o un profilo Instagram può avere conseguenze vitali angoscianti come quelle subite dagli androidi in Blade Runner. Perdere un account Instagram è come perdere la prova della nostra esistenza, anche se è stata costruita artificialmente come la memoria dei replicanti, selezionando e persino inventando ricordi che ci mostrano sempre felici, perfetti, esemplari, attraenti, senza un accenno di sofferenza, di angoscia o di qualsiasi sentimento doloroso che, pur facendo anch’esso parte della nostra condizione umana e delle nostre esperienze, vogliamo tenere lontano, quasi ossessivamente, da qualsiasi percezione possano avere di noi…
Un mio amico l’ha descritta così (e io la metto così): “Su Instagram sembra che nessuno si sia mai sporcato il culo quando va a cagare”.

Il potere della fotografia
La fotografia ha ancora oggi il potere di essere considerata la ricreazione visiva più vicina alla verità. La maggior parte delle persone la percepisce ancora come un riflesso accurato della realtà ed è paradossale quando viviamo in un’era digitale in cui ogni immagine che ci arriva può essere stata manipolata a un tale livello di perfezione che la copia può finire per superare l’originale in realismo (“più umano dell’umano”).
Ma questa è anche l’epoca delle fake news, e anche se tutto può essere sospettato, in fondo sembra che abbiamo bisogno di essere sbugiardati perché la realtà è sempre più indigesta.
Ma questa contraddizione della fotografia è un’esclusiva dei giorni nostri? Non lo è affatto. La fotografia non è lo specchio della realtà, né oggi con tutti gli strumenti digitali a nostra disposizione, né prima quando i processi erano chimici e analogici. La fotografia è, in ogni caso, un’IMITAZIONE della realtà e anche se non c’è un’intenzionalità cosciente di manipolazione nel creare un’immagine fotografica, questa nasce sempre da un atto totalmente soggettivo. Perché dal momento stesso in cui inquadriamo prima di scattare, stiamo filtrando a nostro modo la realtà che si trova al di là dell’obiettivo della nostra macchina fotografica.
La fotografia è un’IMITAZIONE della realtà e anche se non c’è un’intenzione cosciente di manipolazione quando si crea un’immagine fotografica, questa nasce sempre da un atto totalmente soggettivo.
Giriamo di nuovo la vite
Joan Fontcuberta racconta un aneddoto personale nel suo libro El beso de Judas. Fotografía y verdad, che si spinge oltre per quanto riguarda l’incredibile dimensione dell’atto fotografico. Il libro ha già un anno di vita (Editorial Gustavo Gili 1997) ma è ancora estremamente attuale anche se è stato scritto prima del boom digitale.
Fontcuberta racconta che nel 1988, dopo una gravidanza complicata, sua moglie diede alla luce la figlia Judit, che nacque prematura e con prognosi di vita così precarie da dover trascorrere tre mesi in un’incubatrice, all’interno di una stanza enorme, alla quale aveva accesso solo il personale medico, costringendo i genitori a rimanere dall’altra parte di un vetro divisorio, non sapendo bene dove si trovassero i loro bambini in un simile labirinto di incubatrici. Ma Fontcuberta, il giorno stesso della nascita, ebbe l’idea di sfruttare il suo status di fotografo e convinse un’infermiera a entrare con la sua macchina fotografica e a scattare alcune foto della figlia, con l’intenzione di mostrarle alla madre, che era ancora sotto gli effetti dell’anestesia e non aveva ancora potuto incontrare la neonata. Si recò rapidamente nel suo laboratorio e sviluppò la pellicola da cui estrasse alcuni contatti di carta con le immagini di Judit nell’incubatrice.
Il bacio di Giuda. Fotografia e verità

Il bacio di Giuda. Fotografia e verità. Joan Fontcuberta (Editoriale Gustavo Gili, 1997)
Quando Marta, sua moglie, iniziò a riprendersi dal periodo post-operatorio, Joan decise di mostrarle i contatti fotografici di Judit. Logicamente, entrambe si commossero vedendo per la prima volta il loro bambino da vicino, anche se in realtà il bambino si trovava in un’altra stanza lontano dal momento che stavano vivendo, felici, eccitati, commossi… Quei contatti erano la prova della vita e avevano adempiuto alla loro missione di “fornire informazioni visive accurate e affidabili”.
Ma ora vi farò le stesse domande che improvvisamente hanno iniziato a passare per la testa di Joan Fontcuberta: cosa sarebbe successo se l’infermiera avesse commesso l’errore di fotografare un bambino diverso da Judit? Che effetto avrebbe avuto il fatto che il bambino fotografato non fosse Judit sul momento vissuto da Joan e Marta, guardando i contatti, e il fatto che il bambino fotografato non fosse Judit? Beh, nessuna. In quel momento, quando Marta e Giovanna guardano i contatti, non c’è nulla che possa far loro dubitare che la bambina fotografata sia la loro figlia Judit, e se così non fosse stato, avrebbero vissuto e provato le stesse emozioni di fronte alla prova inconfutabile dell’esistenza della loro neonata.
Nella mia carne
Nel settembre 1989 avevo appena compiuto 15 anni e già smanettavo con la Werlisa di mio padre. A quel tempo la fotografia non significava nulla di più per me di quanto non significasse per qualsiasi persona comune. Fotografare per ricordare o semplicemente fotografare per il gusto di fotografare, come se la macchina fotografica fosse solo un giocattolo. Quel settembre, i miei genitori mi permisero di portare i miei amici di allora a trascorrere qualche giorno nella casa di famiglia che avevamo in una piccola tenuta di montagna e che, dopo la morte dei miei nonni paterni, stavamo per vendere. Era come un addio con i colleghi a un luogo in cui avevo trascorso tutte le estati della mia infanzia. Immagino sia questo il motivo per cui i miei genitori accettarono con riluttanza di accettare un tale conclave di ragazzi e ragazze adolescenti in preda all’effervescenza emotiva e da soli.
Naturalmente mi lessero le condizioni per accettare l’accordo e una di queste era che in nessun caso si sarebbe potuto toccare un enorme pezzo di marmo circolare, uno di quelli che un tempo si reggevano su quattro gambe, come un tavolo da terrazza all’aperto. Mio padre, allora molto più sollecito, mise bene in chiaro che la permanenza dei miei testicoli nello stesso posto in cui si trovavano era indissolubilmente legata alla permanenza intatta del masso circolare.
La Werlisa di mio padre
Proprio il giorno dopo io e un amico abbiamo baciato il telone con un vespino su una delle tante salite dell’urbanizzazione e siamo finiti un po’ ammaccati. Quando siamo tornati a casa (noi e la moto), il resto della banda aveva appena finito di cucinare la paella (o qualcosa che le assomigliava) e i tavoli dovevano essere apparecchiati per poter mangiare tutti insieme.
Una delle ragazze si è prestata a disinfettare le nostre ferite e proprio in quel momento qualcuno ha preso la Werlisa e ci ha scattato una foto tra battute e scherzi sulla mia innata incapacità di guidare veicoli a due ruote.
Il fatto è che, dopo aver terminato le cure, scoprii che qualcuno aveva preso il pezzo di marmo da cui erano (de)appesi i miei genitali e lo aveva posizionato sulla struttura con le gambe, e stava per scaricarci sopra il sostituto della paella per quasi 15 commensali. Il “fermati lì” si è sentito anche in Madagascar, e dopo è iniziata una discussione tra battute e risate in cui non c’era modo di scoprire chi avesse preso la pietra proibita e l’avesse sistemata come supporto per l’enorme paella.
La fotografia che ha cambiato tutto
Una settimana dopo, già nel negozio di sviluppo, stavo riguardando tutte le fotografie di quei giorni prima di pagare, quando mi sono imbattuto nella foto che ci avevano scattato mentre curavano le nostre ferite, e wham! proprio dietro la scena, sono apparsi gli autori del “crimine” nel bel mezzo del loro lavoro. In quel momento, anche se non ne ero ancora consapevole, qualcosa è scattato nella mia testa.

La fotografia che ha cambiato tutto
Quello che per la stragrande maggioranza non sarebbe stato altro che l’aneddoto di una buffa coincidenza, per me è diventato il punto di partenza del mio rapporto con la fotografia per 30 anni e tutto ciò che ha portato con sé. Ero affascinato da un’immagine che non si limitava a chiarire un’incognita, peraltro non molto importante, ma mi rivelava, una settimana dopo l’evento, la scena completa di un momento che all’epoca avevo vissuto solo in parte. Divenne una rivelazione e solo un paio di mesi dopo scattavo le mie prime foto con un’altra fotocamera presa in prestito, questa volta con una Olympus OM-1, che ho ancora.
Sono rimasto affascinato da un’immagine che non solo mi ha chiarito un mistero, ma mi ha rivelato, una settimana dopo l’evento, la scena completa di un momento che all’epoca avevo vissuto solo in parte…
Epilogo
Negli ultimi anni si è parlato molto della fine della fotografia, nello stile di Video Killed The Radio Star. Queste “fini di” sono logiche quando lo sviluppo tecnologico e sociale di qualsiasi processo evolutivo implica un confronto tra ciò che conosciamo bene, e che quindi ci garantisce sicurezza, con ciò che è sconosciuto (e inevitabile) e minaccia la nostra presunta zona di comfort. È la paura del cambiamento e dei sacrifici che spesso comporta.
In definitiva, la fotografia non è scomparsa come il video non ha ucciso le star della radio. Si è semplicemente evoluta con i suoi pro e i suoi contro. E soprattutto si è “democratizzata”, anche se questo ha comportato la massificazione del suo uso (scattare o creare foto) e la banalizzazione di un processo che va ben oltre l’atto di premere un pulsante su un dispositivo che cattura immagini.
Viviamo in una bolla tecnologica
Viviamo ormai in una bolla tecnologica che crea continuamente nuovi gadget, spesso di dubbia necessità. Un eccesso di risorse che, oltre a offrire opzioni, spesso genera una vera e propria ansia, soprattutto quando si tratta di valutare l’impegno che comporta tenersi aggiornati per coloro per i quali la fotografia non è semplicemente un’opzione di svago, ma un mezzo professionale per guadagnarsi da vivere.
La fotografia ai tempi della #fotografi@ (prima parte)
Nella prima parte di questa serie di post sulla fotografia in tempi di #fotografi@, ho commentato che per molti fotografi che provengono dall’analogico, per quanto ci siamo adattati a queste nuove regole del gioco, che nel mio caso ho già riconosciuto di non aver fatto a malincuore perché sono sempre stato più un apprendista che un maestro. La sensazione che rimane è agrodolce, forse perché viviamo una battaglia interna tra l’adattamento e l’equilibrio con gli aspetti più essenziali (ed emotivi) dell’atto fotografico, perplessi e in picchiata, in mezzo a questa “furia di immagini” che ci ha spogliato, in una certa misura, del nostro mestiere di artigiani della fotografia.
Viviamo una battaglia interiore tra l’adattamento e l’equilibrio con gli aspetti più essenziali (ed emotivi) dell’atto fotografico, perplessi e in picchiata, in mezzo a questa “furia di immagini” che ci ha, in un certo senso, spogliato del nostro mestiere di artigiani della fotografia.
È stata questa condizione professionale a farmi non solo amare la fotografia, ma anche a volerla capire in tutte le sue dimensioni. Per ragioni a me sconosciute, gli aspetti tecnici delle cose, sia nella gestione delle apparecchiature analogiche che in seguito con i processi digitali, non mi sono dispiaciuti, forse perché vi ho sempre trovato una logica che, purtroppo, non sono riuscito ad applicare a molti aspetti della mia vita personale. Per questo, quando ho imparato a fare qualcosa velocemente, non sono mai riuscita a sentirmi piena e ho sempre avuto bisogno di saperne di più. Di scoprire ciò che non mi è visibile a prima vista.
Mi immagino, a volte, nei panni (😉 ) di Rick Deckard, che esplora le fotografie con la macchina Esper e scopre tutto ciò che si nasconde dietro gli angoli di visione non visibili nell’immagine originale. Ma non solo. La mia macchina Esper mi permette di andare oltre la stanza fotografata e di oltrepassare i limiti dell’inquadratura fino a scoprire un intero mondo congelato in una frazione di tempo, con i suoi paesaggi, le sue case, le sue strade e coloro che lo abitano, totalmente statici, braccati in una sorta di fotografia infinita, prova inconfutabile che tutto ciò che mi circonda, e oltre, esiste.
Musica per questo post:
Mal di testa per la vostra attività di fotografia? Prendete un’Arcadina
Mal di testa per la vostra attività di fotografia? Prendete un’Arcadina
Realizzate il vostro sogno di diventare fotografi professionisti con l’aiuto delle nostre soluzioni aziendali. Ora è possibile creare un sito web e un’attività commerciale gratuitamente per 14 giorni senza alcun impegno di permanenza.
Grazie alle soluzioni aziendali di Arcadina per i fotografi, i vostri problemi di lavoro spariranno.
In caso di domande, il nostro Servizio Clienti è sempre pronto ad aiutarvi 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Vi ascoltiamo.